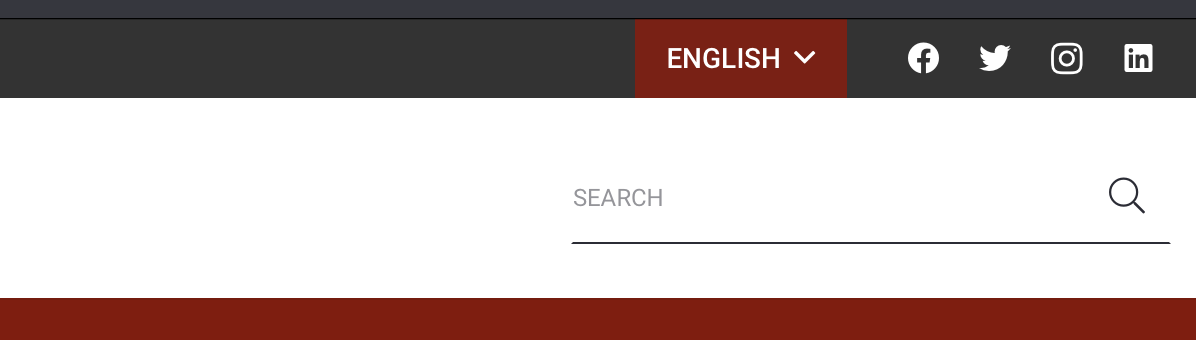Il ruolo dei brevetti nell’industria farmaceutica
I brevetti farmaceutici sono una pietra miliare dell’ecosistema dell’innovazione, fornendo incentivi essenziali alle aziende per investire nel processo costoso e dispendioso in termini di tempo dello sviluppo di farmaci. Il prodotto farmaceutico medio richiede oltre un decennio e circa 2,6 miliardi di dollari per essere immesso sul mercato, dalla scoperta iniziale all’approvazione normativa. Senza la protezione dei brevetti, sarebbe difficile per le aziende recuperare questi investimenti, poiché i concorrenti potrebbero facilmente produrre e vendere versioni generiche di un farmaco di nuova concezione a una frazione del costo.
I brevetti concedono un monopolio temporaneo, di solito della durata di 20 anni dalla data di deposito, durante il quale il titolare del brevetto ha il diritto esclusivo di produrre, commercializzare e vendere il farmaco. Questa esclusività consente all’azienda di fissare prezzi che riflettono sia le spese di ricerca e sviluppo che il rischio di fallimento (dato che la maggior parte dei farmaci candidati non supera gli studi clinici). I profitti risultanti finanziano l’innovazione futura e compensano l’elevato tasso di abbandono nella ricerca farmaceutica.
Il sistema dei brevetti, pur essenziale per le aziende farmaceutiche, non è privo di critiche. I critici sostengono che i brevetti possono portare a prezzi gonfiati dei farmaci, rendendo i farmaci essenziali inaccessibili a molti, in particolare nei LMIC. I prezzi elevati dei farmaci, come quelli osservati con i trattamenti per l’HIV/AIDS negli anni ’90 o più recentemente con le terapie antitumorali e i farmaci biologici, sottolineano la tensione tra la protezione dell’innovazione e la garanzia della salute pubblica.
Copyright vs. brevetti: comprendere i diritti di proprietà intellettuale nel settore farmaceutico
Mentre sia il copyright che i brevetti sono forme di protezione della proprietà intellettuale (IP), servono a scopi distinti, specialmente nell’industria farmaceutica. Il copyright protegge principalmente le opere creative, come libri, film e software, concedendo al creatore i diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e visualizzazione dell’opera. Al contrario, i brevetti proteggono le invenzioni, compresi i nuovi farmaci, i processi di produzione e i dispositivi medici.
Per le aziende farmaceutiche, i brevetti sono molto più importanti dei diritti d’autore. Un nuovo farmaco è tipicamente il risultato di anni di sperimentazione, test e sviluppo, rendendo la protezione brevettuale cruciale per recuperare i costi dell’innovazione. I brevetti coprono la composizione di un farmaco, il suo metodo di utilizzo e il processo di produzione. In alcuni casi, i brevetti secondari possono essere depositati per estendere l’esclusività del mercato, ad esempio brevettando una nuova formulazione o metodo di somministrazione per un farmaco esistente.
Le differenze tra brevetti e diritti d’autore riflettono la natura dell’innovazione farmaceutica, che riguarda più la scoperta scientifica e meno l’espressione creativa. Mentre i diritti d’autore possono applicarsi a rapporti di studi clinici, pubblicazioni di ricerca o materiali di marketing, i brevetti proteggono l’innovazione fondamentale nello sviluppo di farmaci, salvaguardando la molecola o il trattamento che detiene un valore terapeutico.
Casa farmaceutica
L’industria farmaceutica è un ambiente altamente complesso e competitivo, dominato da due tipi principali di aziende: grandi multinazionali, spesso definite “Big Pharma”, e piccole aziende biotecnologiche. Entrambi fanno molto affidamento sui brevetti per sopravvivere e prosperare, anche se i loro approcci all’innovazione e alla protezione della proprietà intellettuale possono differire in modo significativo.
- Big Pharma e strategie brevettuali: le grandi aziende farmaceutiche in genere mantengono vasti portafogli di brevetti per proteggere le loro scoperte e controllare la quota di mercato. Investono molto in ricerca e sviluppo, con ricavi che spesso superano i miliardi di dollari all’anno, e si affidano alla protezione dei brevetti per generare rendimenti su questo investimento. Aziende come Pfizer, Merck e Johnson & Johnson sono ottimi esempi di aziende farmaceutiche che utilizzano la protezione dei brevetti per salvaguardare i farmaci di successo. – Prodotti che generano vendite annuali superiori a 1 miliardo di dollari. Big Pharma utilizza spesso boscaglie di brevetti, che comportano il deposito di numerosi brevetti attorno a un singolo farmaco, per estendere l’esclusività del mercato e bloccare la concorrenza dei generici.
- Startup biotecnologiche e Venture Capital: anche le aziende biotecnologiche più piccole dipendono dai brevetti, ma per motivi diversi. Per molte startup, i brevetti sono essenziali per attrarre finanziamenti di venture capital. Queste aziende spesso si concentrano sulla ricerca in fase iniziale, come lo sviluppo di nuovi bersagli farmacologici o sistemi di consegna, e quindi si affidano a partnership o acquisizioni da parte di aziende più grandi per portare i loro prodotti sul mercato. Senza una forte protezione brevettuale, le startup biotecnologiche avrebbero difficoltà a garantire gli investimenti necessari per sviluppare nuove terapie, poiché i potenziali investitori sarebbero preoccupati per il rischio di imitazione da parte dei concorrenti.
Entrambi i tipi di aziende sono fondamentali per l’ecosistema dell’innovazione farmaceutica. Big Pharma ha le risorse per assumere farmaci attraverso il lungo e costoso processo di approvazione normativa, mentre le aziende biotecnologiche spesso aprono la strada nella fase iniziale di ricerca e sviluppo. Insieme, formano una relazione simbiotica che guida l’innovazione farmaceutica.
Il processo di sviluppo dei farmaci e le tempistiche dei brevetti
Il processo di sviluppo del farmaco è notoriamente lungo, con diverse fasi chiave che contribuiscono al costo complessivo e al tempo necessario per portare un nuovo farmaco sul mercato. Queste fasi includono:
- Scoperta e ricerca preclinica: i ricercatori identificano potenziali bersagli farmacologici (come proteine o geni coinvolti in una malattia) e conducono test di laboratorio per valutarne gli effetti. Questa fase può richiedere diversi anni ed è spesso la più incerta, poiché molti candidati farmaci non riescono a mostrarsi promettenti nei test precoci.
- Sperimentazioni cliniche (Fasi I-III): una volta che un farmaco mostra un potenziale nella ricerca preclinica, entra negli studi clinici, che prevedono la sperimentazione del farmaco sull’uomo. Gli studi clinici sono divisi in tre fasi (ogni fase può durare diversi anni e i farmaci possono fallire in qualsiasi momento):
- Fase I: verifica la sicurezza del farmaco in un piccolo gruppo di volontari sani.
- Fase II: valuta l’efficacia del farmaco in un gruppo più ampio di pazienti con la condizione target.
- Fase III: conduce test su larga scala per confermare l’efficacia e monitorare gli effetti collaterali.
- Revisione e approvazione normativa: dopo aver superato con successo gli studi clinici, il farmaco viene presentato agli organismi di regolamentazione (come la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti o l’Agenzia europea per i medicinali (EMA)) per l’approvazione. Questo processo può richiedere ulteriori anni poiché le autorità di regolamentazione esaminano i dati per sicurezza, efficacia e qualità della produzione.
- Post-approvazione e commercializzazione: una volta approvato, il farmaco entra nel mercato, dove è tipicamente protetto da brevetti per il resto del periodo di 20 anni. Tuttavia, a causa della lunghezza del processo di sviluppo, l’orologio dei brevetti inizia a ticchettare molto prima che il farmaco raggiunga il mercato, lasciando la maggior parte dei farmaci con solo 7-12 anni di effettiva esclusività sul mercato.
Durante il periodo post-approvazione, le aziende spesso si impegnano nella commercializzazione e possono perseguire brevetti secondari su diverse formulazioni, combinazioni o usi del farmaco per estendere il periodo di esclusività oltre la scadenza del brevetto originale.
Brevetti come spada a doppio taglio: incoraggiare l’innovazione vs. limitare l’accesso
Mentre i brevetti sono essenziali per incentivare l’innovazione farmaceutica, creano anche sfide in termini di accesso globale ai farmaci. I farmaci protetti da brevetto sono spesso fuori dalla portata di molti nei paesi in via di sviluppo, dove i sistemi sanitari pubblici sono sottofinanziati e i pazienti non sono in grado di pagare prezzi elevati per i trattamenti. Questa disparità è diventata particolarmente evidente durante la crisi dell’HIV/AIDS della fine del XX secolo, quando i farmaci antiretrovirali erano disponibili nei paesi ad alto reddito ma inaccessibili a milioni di pazienti nei LMIC.
Per affrontare questo problema, gli accordi internazionali, come la Dichiarazione di Doha sull’accordo TRIPS e la salute pubblica (2001), hanno cercato di fornire una certa flessibilità nell’applicazione dei brevetti, consentendo ai paesi di rilasciare licenze obbligatorie in caso di emergenze di salute pubblica. Una licenza obbligatoria consente a un governo di autorizzare la produzione di un farmaco brevettato senza il consenso del titolare del brevetto, di solito in cambio di una tassa. Questo meccanismo è stato utilizzato con successo per espandere l’accesso a trattamenti salvavita in determinate circostanze, ma la sua applicazione rimane controversa, con molti paesi sviluppati e aziende farmaceutiche che lo considerano una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha portato una rinnovata attenzione ai limiti del sistema dei brevetti, in particolare in termini di accesso ai vaccini. Mentre la protezione dei brevetti ha incentivato il rapido sviluppo dei vaccini Covid-19, ha anche sollevato preoccupazioni per la distribuzione ineguale, con i paesi ad alto reddito che assicurano la maggior parte delle forniture di vaccini precoci, lasciando molti LMIC dietro.
Italia prima del 1978 – Senza Brevetti per Invenzioni Farmaceutiche
In Italia la protezione brevettuale per i prodotti farmaceutici divenne disponibile solo nel 1978. A quel tempo la Corte Costituzionale (20/03/1978 n. 20) aveva pronunciato l’incostituzionalità dell’art. 14 del R.D. 29/06/1939, n. 1127 (legge sulle invenzioni industriali) che vietava la concessione di brevetti per invenzioni farmaceutiche, sulla base di alcune giustificazioni “morali”. La Suprema Corte si è pronunciata a favore di diciotto aziende farmaceutiche, tutte straniere, chiedendo l’escussione dei brevetti stranieri sui prodotti medicali in Italia. Ma sorprendentemente, nonostante questa completa mancanza di qualsiasi protezione brevettuale, l’Italia aveva sviluppato una forte industria farmaceutica: alla fine degli anni ’70 era il quinto produttore mondiale di prodotti farmaceutici e il settimo esportatore [1].
La spesa in R&S farmaceutica in Italia è passata da 123 miliardi di lire nel 1978 a 1.632 miliardi di lire nel 1992, passando dal 7,78% del fatturato all’11,99% [2]. I nuovi prodotti farmaceutici di origine italiana commercializzati tra il 1975 e il 1989 rappresentavano il 9,2% del totale mondiale di 775, mentre quelli definiti “di sostanziale innovazione terapeutica” sono aumentati dall’1,25% del totale mondiale nel 1975-79 al 2,78% nel 1980-84 e al 3,9% nel periodo 1985-89.
Ma una forte evidenza che concentrazione e tutela brevettuale vanno di pari passo viene dall’esperienza italiana prima e dopo lo spartiacque del 1978. Prima del 1978 l’industria farmaceutica italiana era caratterizzata dalla presenza di un gran numero di piccole e medie imprese indipendenti. Dopo il 1978, la concentrazione del settore procedette rapidamente: il numero totale di imprese indipendenti passò da 464 nel 1976 a 390 nel 1980 e 335 nel 1985. Nello stesso periodo non si è verificata alcuna concentrazione dell’attività produttiva nell’industria farmaceutica degli altri grandi paesi occidentali. L’industria farmaceutica italiana, nel frattempo, ha perso quote di mercato ad un ritmo costante sia a livello nazionale che mondiale [3]. Si può trarre una conclusione: è probabile che i brevetti nel settore sanitario favoriscano strutture industriali più grandi. Per quanto riguarda i mercati più piccoli rispetto agli Stati Uniti, si discute molto se l’impatto economico dei brevetti nelle scienze della vita e il loro ruolo nello stimolare l’innovazione e attrarre investimenti dal settore nella R&S medica siano suscettibili di causare effetti positivi o meno [4].